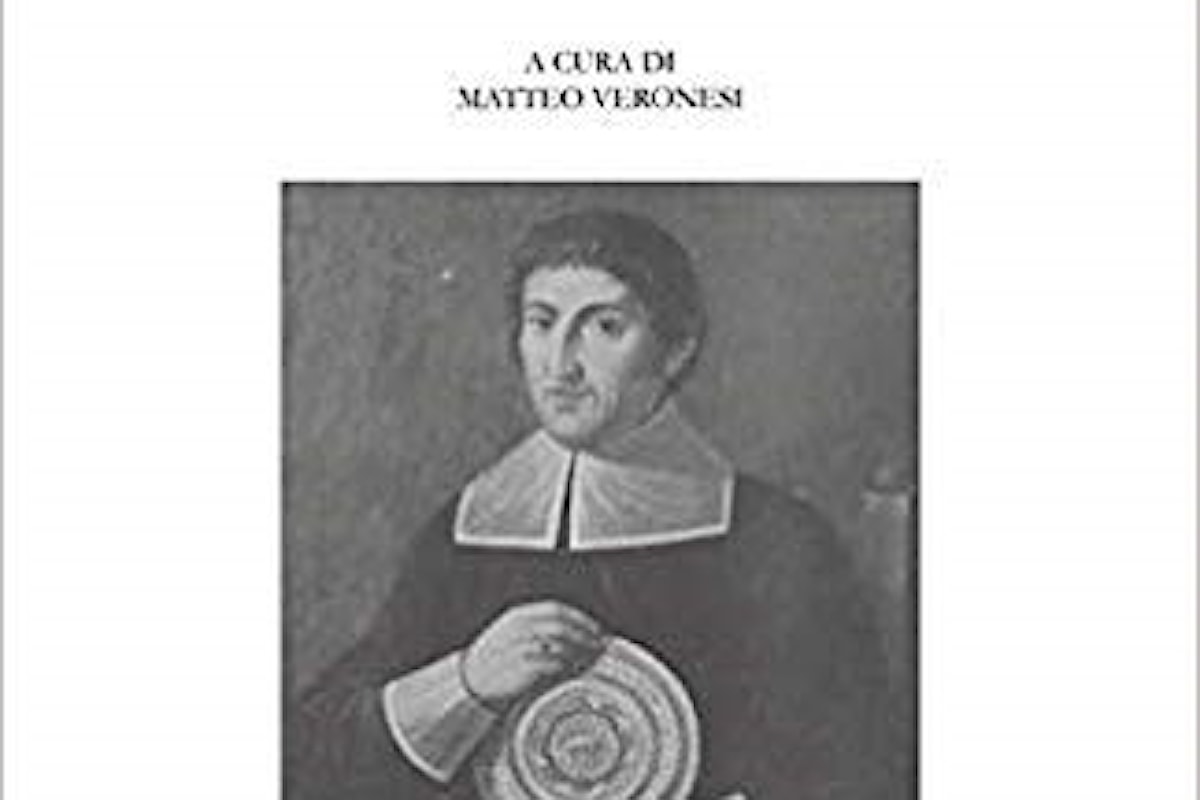Vissuto tra Sei e Settecento, Arduino Suzzi (del quale è uscita da non molto un'essenziale antologia, Sui nomi divini. Passi scelti dalle Origini hebraiche delle tre lingue e dagli scritti esoterici, a cura di Matteo Veronesi, Clori, Firenze 2020, gratuitamente scaricabile all'indirizzo http://edizioniclori.wdfiles.com/local--files/collane/Suzzi_Sui_nomi_divini.pdf ) ripropone, pur in epoca tanto mutata, gli afflati e gli ideali dell’Umanesimo e del più maturo Rinascimento. Nella sua opera maggiore, Le Origini Hebraiche delle tre lingue Latina, Greca et Volgare (che non ottenne l’imprimatur), pare di ritrovare lo spirito del grande cabalista cristiano Johannes Reuchlin, che nel De arte cabalistica così tripartiva la sequenza delle lettere dell’alfabeto ebraico: “Da aleph a yod sono simboleggiate le schiere e i cori degli angeli; dalla lettera kaf alla lettera ṣade si designano gli ordini dei cieli; da ṣade a taw si arriva ai quattro elementi con le loro forme” (in Giulio Busi, L’arte cabalistica, 1995, p. 197).
La lingua ebraica sembra superiore a ogni altro idioma, perché le lettere del suo alfabeto contengono tutti i livelli di realtà. Di ogni altra lingua essa è anche l’origine, secondo una tradizione che identifica la prima lingua parlata dall’uomo, quella adamitica, con l’ebraico stesso. È interessante notare (fondamentali, al riguardo, gli studi di Maria Corti) come Dante affronti il problema della struttura originaria di questa, come delle altre lingue derivate dalla confusione babelica, attraverso il concetto di forma locutionis, concreata da Dio insieme all’anima del primo uomo. Come l’anima è principio e forma del corpo, anche la lingua è costituita da un principio formale e un elemento materiale, intendendo, con il primo, tutti e tre i livelli della lingua: lessico, morfologia e sintassi. In ogni lingua, creata secondo umani criteri, si cela un frammento della struttura originaria della lingua prima, dalla struttura perfetta e cristallina, mezzo terso e trasparente che nella parola specchia e riflette l’essenza delle cose.
Chiedendosi quale sia stato il primiloquium, il primo actus locutionis di Adamo, Dante risponde che esso è coinciso con l’invocazione gioiosa del Nome di Dio, identificato con l’ebraico ‘El. La prima parola pronunciata da Adamo, al di qua della Storia e del dolore della caduta, fu proprio l’esclamazione gioiosa di quell’‘El, che da San Girolamo in poi era considerato primum Dei Nomen, il primo e il più originario dei Nomi divini. Nel XXVI canto del Paradiso, Adamo stesso pronuncerà la famosa ritrattazione della concezione sin qui esposta, in favore della storicità e convenzionalità di ogni lingua, ivi compresa l’ebraica: “Pria ch’i’ scendessi a l’infernale ambascia/ I s’appellava in terra il sommo bene / onde vien la letizia che mi fascia; / e El si chiamò poi: e ciò convene, / ché l’uso d’i mortali è come fronda / in ramo, che sen va e altra vene”. Anche la lingua originaria, sacra e perfetta, consegnata dal peccato alla Storia, ne ha subito le inevitabili mutazioni. Prima dela diaspora l'ebraico era stato preservato nella sua purezza per tre ragioni: la creazione stessa del primo uomo, immagine e somiglianza di Dio, per cui la perfezione dell’uno è, anche linguisticamente, riflesso di quella dell’altro; il non avere gli Ebrei acconsentito e partecipato alla costruzione della Torre di Babele, motivo per il quale la loro lingua non fu sottoposta alla corruzione cui andarono incontro le altre, e ciò anche in vista dell’Incarnazione e dell’annuncio del Vangelo del Cristo, che non poteva avvenire in lingua non pura; infine, il fatto che Adamo avesse gioiosamente esclamato il Nome divino, quale ringraziamento al Padre per aver ricevuto l’essere e la luce.
Le concezioni rinascimentali delle lingue e delle teologie antiche furono dunque il punto di arrivo di una lunga tradizione (attestata ad esempio da Filone di Alessandria), secondo la quale era stato Israele a insegnare la sapienza ad altri popoli. Mosé e il Giudaismo, lungi dal rappresentare una cultura barbara, in tutto inferiore a quella greca, venivano intesi come le sue divine fonti. Dal Corpus Areopagiticum il Suzzi traeva, infine, la tensione a risalire dalla frantumazione dei linguaggi al Verbo, al Logos, alla Parola pura, esemplificata nei Nomi divini, sempre parziali pur nella loro pregnanza. Ma il motore di questo tendere alla Parola Unica è certamente rappresentato dalla mistica ebraica. Solo in essa vengono armonizzate pienamente le due opposte facce del segno linguistico: il significante e il significato. A partire dal Cratilo platonico, invece, il primo diviene puro analogon del secondo, così come il segno, nella sua interezza, è analogon della realtà nominata.
La visione ebraica del segno è totalmente diversa già nella tradizione rabbinica precedente, e la visione cabalistica delle sefirot (emanazioni, gradi e energie che, a partire dall’En-sof, ovvero dall’infinità di Dio, traducono la vita intradivina in extradivina, modificando il concetto di creazione dal nulla in creazione da Dio in Dio) non fa che ribadirla e rafforzarla. Il significante possiede un valore proprio e autonomo rispetto al significato, che è anzi costruito da esso (le lettere che compongono i nomi sono la cosa stessa, la forza creatrice che la fa essere), in maniera del tutto parallela a quella per cui i gradi della vita divina, le sefirot appunto, non sono entità logiche e statiche, non essenze, ma forze e potenze, il cui coeso dinamismo trapela nella graduale e mai completa rivelazione dell’En-sof, l’Infinito. La sequenza di lettere che compone il segno linguistico, anzi la stessa lettera singola, la sua stessa forma grafica è viva, creatrice, portatrice di significanza. Innumerevoli sono gli espedienti di permutazioni delle lettere, gli acrostici, gli anagrammi, le trasposizioni di parole che permettono al cabalista interpretazioni del testo biblico sempre più profonde e inusitate.
Scorrendo il testo di Arduino Suzzi, si possono contare diversi esempi di questo modo di conciliare significato e significante, non solo a partire dall’ebraico ma, ad imitazione di quello, anche dal latino e dal greco. "Deus (dice Pompeo Festo) dictus est, quod ei nihil desit, vel quia omnia commodo hominibus dat, sive a Graeco deos, quod significat metum, eo quod hominibus metus sit. Sed magis constat id vocabulum ex Graeco theos, esse dictum, aspiratione dempta, qui mos antiquus nostris frequens erat. Ma nella lingua volgare rimase l’anticata voce dius, come appo i Latini nel numero plurale alcuni casi da quella inflessi, cioè il nominativo e il dativo, dii e diis. […] E in vero tra gli altri nomi, che si attribuiscono a Dio, quello di Giove pare che sommamente gli si convegna: perciocché Giove è detto dal giovare, e da Dio viene agli uomini ogni giovamento, e aiuto". Più avanti il Suzzi rifiuta l’etimologia di theòs proposta nel Cratilo di Platone: "Fu Iddio da’ Greci chiamato theòs, come vuol Platone nel libro ch’ei fece dell’etimologie e significazioni de’ nomi, inscritto il Cratilo, dal verbo théo, che significa correre: conciossiaché quegli antichi huomini vedendo il sole, la luna e le stelle correre per il cielo, pensarono, che fossero numi: e così li chiamarono theoi, cioè dei, para to thein dia ton ouranon, perciocché corressero per i cielo: comeché altri assegnino a questa voce greca theos l’etimologia apo tou theoreisthai, idest a spectando, cum omnia aspiciat, et cernat. Ma questa etimologia, quanto alla deductione, non è vera: né posso acconsentire a quella di Platone: perché noi con il lume della Scrittura Sacra sappiamo che i primi discendenti di Noé haveano cognitione del vero Iddio: e nella divisione delle lingue, come le altre appellationi, così è molto più quella di cui dobbiamo credere, che fusse da divino afflato inspirata nelle menti e nelle lingue degli huomini: il che chiaro da questo si può conoscere, perché in tutte le lingue (come diremo) il nome di dio fu di quattro lettere composto".
Rigettate le precedenti, variegate ipotesi, ha inizio un'articolata riflessione sui nomi divini nella lingua ebraica. Viene prima presa in considerazione la possibile derivazione del latino deus dall’ebraico day, che significa bastante a Sé stesso (ma anche ciclico e armonioso), in sincretico accordo con l’Etica Eudemia, VII, 12 di Aristotele in cui Dio è detto sibi sufficiens, non bisognoso e non mancante di nulla. Interessante anche il richiamo al Nome שדי dal significato di Onnipotente, costituito da una radice trilittera che contiene proprio la parola day, nel senso inteso da Talmud, Ḥagigah 12a, ove Dio è detto Onnipotente, ‘El Šaddaj , perché pone un limite alla Sua stessa creazione. Circa la radice trilittera del Nome divino, Suzzi proprone che esso "sia nella nostra lingua ad imitazione della lingua Siriaca e Chaldea; che si ha non solo tetragrammato elaha, ma ancora trigrammato elah, per la significazione de’ misteri sopradetti".
Tuttavia, per la sostanziale equivalenza di Unum et Ens, "appresso i Filosofi, non volle Iddio con altro nome chiamarsi, che Iehoah: la qual voce dell’idioma Hebraico interpretasi fuit qui est; nome di Dio ineffabile appresso gli Hebrei: che era detto Sanctum domino, quasi nome santificato al Signore, e per eccellenza Tetragrammaton, quasi nome di quattro lettere: e portavasi dal Sommo Sacerdote scolpito in una lamina di purissimo oro, pendente dalla tiara sopra la di lui fronte: Exod. Cap. 28". Arduino identifica l’impronunciabile Tetragramma, Y-H-W-H, con l’Essere (citando a supporto un passo dell’Apocalisse, 1.8: Io sono Colui che è, che era e che viene, sottolineando la continuità fra civiltà ebraica e messaggio cristiano) secondo un’interpretazione ancor oggi condivisa. Un Essere non però immobile, ma còlto, come osserva il curatore, “nel suo triplice e uno dispiegamento temporale (principio, divenire, fine), accostandolo inoltre (con una pseudoetimologia peraltro suggestiva) al latino Iovis. Si avvertiva anche qui, forse, l’influsso di Reuchlin, che associava l’ebraico ehieh all’idea platonica dell’Essere, to on, e la sillaba hu all’idea dell’Ineffabile e dell’inconoscibile. Analogamente, lo Yod indicava la primalità, l’origine, lo He il divenire, il dispiegarsi dell’essere nel tempo, il Waw l’interconnessione fra gli opposti, fra l’eterno e il tempo, fra l’umano e il divino: insomma l’essenza originaria, eterna del pensiero e dell’espressione, specchi dell’essere, e il loro temporale fluire e manifestarsi nel linguaggio, nel suo snodarsi ed articolarsi in quanto discorso. Ma, più in generale, questa sapiente ars combinatoria (nella quale, osservava Ficino introducendo il platonico Cratilo, si fondevano e cooperavano “natura” e “consuetudo”, l’originaria, quasi alchemica simpatia e analogia fra nomi e cose, fra linguaggio e realtà, e la mediazione razionale del rapporto intercorrente fra i due dominî) trovava riscontro in numerosi luoghi della vastissima tradizione della Mistica ebraica. Subtilitas, soffio del pensiero, finissimo anelito alla trascendenza, il Nome Divino, in quanto unione degli opposti, fonde uno e molteplice, identità e alterità, stabilità e divenire, immanenza e trascendenza». Si può precisare che le quattro lettere che compongono il Nome corrispondono a precise sefirot o emanazioni, costituendo una sorta di piccola summa dell’albero sefirotico, una rappresentazione della sintesi e della compresenza di tutti i livelli del reale coesistenti nello sguardo di Dio. Esse corrispondono anche ai Parṣufim o Volti divini, dimensioni parallele alle sefirot: Padre, Madre, Figlio, Figlia. Tutto ciò che esiste si fonda sul mistero di questo Nome e delle lettere che lo compongono. Un altro parallelo connette le quattro lettere del Tetragramma ai Quattro Mondi o livelli spirituali, creati, tramite innumerevoli e progressivi ṣimṣumim (contrazioni), dall’inesauribile forza vitale di ‘En Sof nella catena discendente dell'Esistenza, dal più astratto e spirituale al più concreto. I quattro reami, dominati ognuno da una diversa sefirah, sono formati di Luce Divina che, intrinsecamente, li colma di sé, secondo la capacità spirituale di ricevere propria di ciascuno. I loro nomi risalgono a Isaia, 43:7: Emanazione, Creazione, Formazione, Azione. Il Nome è sintesi dei quattro Reami, dei quattro livelli dell'universo e della creazione.
Chiude questa quintessenziale antologia una dissertazione del Suzzi sulla famosa Pietra di Bologna, apparentemente un’iscrizione funebre latina del XVI secolo, dedicata a una donna di nome Aelia Laelia Crispis. Iscrizione particolarmente misteriosa e enigmatica, che, fingendosi epigrafe funeraria, sottende forse un mistero alchemico. Essa menziona una Elia Crispis che senza essere né uomo, né donna, né androgino, né bambina, né giovane, né vecchia, né meretrice, né pudica ma tutto, fu uccisa né dalla fame, né dal ferro, né dal veleno ma da tutti questi insieme, e giace né in cielo, né in acqua, né in terra, ma in tutti questi elementi insieme. La lapide è dedicata ad un altrettanto misterioso Lucio Agato Prisco, né marito, né amante, né parente, né triste, né lieto, né piangente. L’iscrizione “rappresenterebbe, per Suzzi, la fusione arcana, lo sposalizio mistico, l'archetipico connubio di Nox (l’omerica e virgiliana «nox nigra») e Sol, Notte e Sole - qualcosa di simile, insomma, al Logos di Eraclito, che è insieme Giorno e Notte, luce e tenebre, o all’Essere di Parmenide, nel quale si incontrano e si intrecciano, per poi dipartirsi, le vie della Notte e del Giorno, o, più da vicino, alla coincidentia oppositorum, alla fusione degli opposti nell’Unomnia, nell'Uno-Tutto, di cui parlava il platonismo rinascimentale, da Cusano a Giordano Bruno”. O, forse, la lapide è letta da Suzzi come null’altro che la rappresentazione della coincidenza di significante e significato, di linguaggio ed Essere, perseguita nella sua esegesi. La Parola è insieme sepolcro e cadavere, simbolo e significato, segno esteriore ed essenza nascosta. E, date le sue virtualmente illimitate potenzialità espressive, può meglio di ogni altro mezzo rappresentare la molteplice unità del creato.
(Tiziana Mayer)